
Molte lacrime, di giorno in giorno; a volte salate, a volte di rabbia, oppure stillate quasi con sforzo per dare peso alla nostalgia che viene prima di addormentarsi, se fuori è stata una giornata d’inverno raggiata, troppo lucida, che richiama un falso d’estate. Anche per gratitudine alla vita c’erano lacrime, nell’attesa di una felicità che non si faceva mai presagio. Lacrime e lacrime, tante che a lei si bagnava la pettorina bianca, orlata di pizzo, annodata col fiocco sul grembiule grigio scuro, di fatica. La pettorina riscattava il grembiule rammendato che, da solo, le avrebbe imposto l’aria di un topo triste. Lei, la ragazza dei mestieri, piangeva e singhiozzava. Anzi, siccome le mani le coprivano a conca tutto il viso, si capiva il suo pianto dai sussulti che le agitavano le spalle. Lo si capiva anche da tergo. Di fianco, la punta del naso le sporgeva di profilo tra le dita, come fosse un altro piccolo dito ancora. Davanti, invece, lo si vedeva dalle macchie umide, ancora un po’ dopo che si era calmata. Era stata di nuovo rimproverata in cucina per qualche mancanza nel servizio, o forse per aver reagito alle osservazioni che le pizzicavano addosso da quando la cuoca anziana era andata in pensione. La cuoca si era licenziata; aveva riempito il baule di rovere per tornare dai suoi, in campagna, quelli che le restavano della famiglia dispersa, “dispersa dalla vita e dalla guerra”, diceva. Vista da dietro, se n’era andata con poca fatica, una borsa per mano a bilanciere; due facchini portavano il baule. Nessuno aveva più voglia di proteggere la ragazza apprendista dagli errori, né di correggerla con le buone, o rincuorarla. Costava fatica, ecco: non è che per gli altri non ci fosse da sgobbare. Nessuno la guidava come prima, sicché non era difficile coglierla in fallo. Lei stessa, selvatica, poco istruita: leggeva male e sentiva cresciuto persino il disagio di muoversi. Molto spesso era in imbarazzo già per non sapere dove tenere le mani mentre ascoltava, o dove guardare nella persona che le rivolgeva le ordinazioni, se nel mezzo del busto o sopra la fronte o con gli occhi socchiusi, verso il basso. – Suppongo fosse così. Vergogne di crescita. Per la mia età, non ero in grado di comprendere i suoi disagi. Ignoravo, d’altronde, se ne avesse sul serio. Per me, era solo la signorina del pianto, una vera campionessa delle lacrime. Incrociandola nel corridoio mentre correva per raggiungere la sua stanza coi passetti frenati, che le facevano squittire le scarpine sulle punte gommate, mi urtava coi fianchi soffici, e mai sgarbati; io mi trovavo di colpo tra le sue gambe, quasi incastrato nel suo grembo ricoperto dal pizzo bianco. Mi faceva sentire un puledro, al sicuro fra i garretti della madre. I vestiti di ciascuno erano, allora, parte organica di chi li indossava: non riuscivo a immaginarmi nessuno di casa senza la sua consueta livrea, come fosse un’escrescenza spontanea, caratteristica della pelle. A volte lei, la signorina del pianto, veniva diretta dalla cucina, e io mi affacciavo dalla sala preferita, quella degli animali impagliati di mio zio – mi aspettavo sempre che gli cadesse giù dalle orbite incollate qualche occhio di vetro, perché non osavo arrampicarmi per cavarli via apposta. Senza guardare, quasi inciampato nella sua corsa, le capitavo col viso al centro dello strofinaccio che la cingeva: di conseguenza, giudicando dall’odore che mi era rimasto sul naso e sulle guance, capivo che fuggiva dalla pulitura del pesce. Oppure mi sentivo, poi, la fronte inebriata di vaniglia o di crema pasticciera: così sapevo d’anticipo cosa avrebbe allietato la cena e che, intanto, la ragazza era stata interrotta dai rimproveri nel mentre la preparava. Qualcuno l’aveva ripresa per motivi di cui non ero nemmeno curioso; cose da grandi, immagino, benché lei non lo fosse poi del tutto. Anzi: passava per l’apprendista giovane, poco più che bambina, e forse non aveva finito le scuole di base. Leggeva mai niente, scriveva poco su pezzetti di carta stazzonata, per lo più la lista della spesa. Però non si fidavano, alle compere ci mandavano poi qualcun altro. Nel corridoio, lei chiedeva permesso, si vedeva che aveva l’urgenza a fior di pelle, ne sentivo un vago odore come se stesse sudando. Chiedeva permesso tastando il muro, lo chiedeva col poco fiato, con la voce bassa, con gli occhi semichiusi. Lo chiedeva perfino a me, che pure ero tanto piccolo da passare per lo più inosservato a chiunque. Subito si ritirava in privato per smaltire il rammarico, o magari qualche rabbia che lei stessa non osava permettersi. Queste fughe di lacrime erano abbastanza frequenti e ormai non mi facevano molta impressione. Ce n’erano di tipo diverso: coi singhiozzi forti, con le mani sul viso, col fazzoletto al naso, con un esile pigolio che teneva le veci del pianto, con le gote rigate e senza espressione, in silenzio. La ragazza, che si chiamava Nella, si riduceva nella sua cameretta; aveva solo un finestrino non esposto, più alto del mento, e in quella penombra fresca, buttata sul letto, dava lo sfogo ai dispiaceri. Se riusciva, chiudeva la porta con la chiave numerata; allora dovevo poggiare l’orecchio al battente di compensato per sentirne i sussulti e perfino delle paroline soffocate, in dialetto, che parevano versi di bestiola. Se invece la crisi era violenta, oppure, al contrario, desolata e languida, la porta rimaneva trascurata, accosta quel tanto da poterla scrutare. La vedevo distesa o seduta sul letto, comunque balbettante di umiliazione al punto che la rete di sostegno mandava un cigolio a sì e no, intermittente, come se l’accompagnasse un grillo domestico. Si metteva anche in ginocchio, per terra, col corpo prostrato sul letto, e le braccia distese, a mani giunte sopra la testa per qualche misteriosa preghiera. A stento raggiungeva il cuscino con la punta delle dita. Da sotto la federa si vedeva sporgere un lembo rosa della sua camicia da notte e l’angolo lucido di una cassettina di legno. Ciascuno ha i propri beni segreti.Nella, Nella – dicevo. Chi preghi? Perché piangi? Ti è morto qualcuno? chiedevo piano, con cautela, spiandola e parlandole anche traverso la toppa della serratura, come fosse un piccolo megafono fra noi. Non volevo peggiorarle l’umore. Lei piangeva sempre, perfino sopra pensiero. La chiamavo ancora, sbirciavo con sforzo il pezzettino di stanza. Per divagare, domandavo: quanti anni hai? – e lei mi sventolava appena la mano per salutarmi, perché stessi tranquillo. Poi metteva una salvietta sulla maniglia, copriva la toppa, e non la vedevo più. Che ne sapevo? Che potevo capire, nella mia confusione? Una ragazza piangeva e quasi anche a me, di riflesso, venivano gli occhi liquidi, da non vederci bene. In quel tremore intuivo le sue dita salutarmi e poi tornare a coprirle la faccia. Se la porta era rimasta socchiusa, la schiena curva col fiocco in vita era l’unico sussulto che si poteva ancora scorgere, di suo. Volevo parlarle dei caprioli, o dei castori, ma rinunciavo. Non avrei osato tentare neppure coi miei preferiti, i galli cedroni. Eh, che portamento, che petto piumato, quei cedroni! Ma persino loro non l’avrebbero spuntata, con quelle lacrime. A qualcuno le bestiole impagliate fanno senso… Restavo un poco ad ascoltare, poi me ne andavo più in là nel corridoio; lei mi aveva pregato: per favore, vai via! – Una volta mi aveva detto tra i sospiri che piangeva per la bellezza di una signorina, che abitava di fronte alla nostra casa. Insegnava danza in una scuola con gli specchi, ed era molto bella, secondo Nella; troppo bella, aggiungeva con umiliazione, e riprendeva a piangere. Lei non avrebbe mai avuto nemmeno un centesimo di quella bellezza. Lei sapeva di non essere preferita. Ero rimasto mortificato per la mia impotenza; certo, anch’io capivo quanto fosse bella la signorina della danza, e avrei voluto che gli specchi mi obbedissero per dare a Nella la sua parte di speranza. Ma a quell’età, così piccolo, mi ubbidivano solo gli animali imbalsamati. Animali. Dicevo: in fila! e loro, tutti insieme, li potevo vedere all’istante ben allineati, pronti a farsi ispezionare, muti di rispetto. Dicevo: attenzione! e tutti rimanevano fissi, concentrati su di me. Di corsa! e spingevo al massimo la mia velocità, pestando i talloni, sicché mi accompagnavano tutti in girandola. Perciò me ne stavo di solito nella sala con le teche, dove nessuno aveva niente da dirmi, dove non c’erano pianti e lacrime, ma sguardi fissi. Sguardi. A me, però, sembrava uno spettacolo meraviglioso, un miracolo, quelle lacrime femminili di nostalgia e di bellezza mancata, e insieme un segreto da grandi; forse troppo intimo e terribile anche per loro. Mistero. Un segreto sepolto nel profondo del suo magro torace. Povera Nella. Sarebbe sempre stata infelice? Si sarebbe ammalata a furia di lacrime? Si sarebbe licenziata come la cuoca? Come mai? Saperlo… Per quel segreto di ragazza, un segreto dell’età che c’è da qui a laggiù – pensavo, e guardavo incantato la sua porta chiusa dopo aver misurato coi passi quanti ce n’era nel corridoio con la passatoia rossa. Passi. Qualcuno più di quindici, non so di preciso; dopo il quindici smettevo di contarli, mi stancavo.Troppi. Dopo il quindici cominciava per me l’indefinito coi numeri grossi, i numeri degli adulti. Numeri. Perché io sono nato il quindici, nel primo mese dell’anno. Quindici. E lì mi fermavo, di fianco alla soglia impedita, chiedendomi molte cose per cui non avevo risposte. Per esempio, se nella vita c’è poi molto da ridere, oppure se la bellezza conta davvero, e perché mai faccia piangere più di uno schiaffo che ti affibbiano per strada quelli già grandi e forti, tanto per passare il tempo: ti fa piangere perché non lo capisci e non lo pareggi più.
L’invisibile, un altro racconto di Marco V. Burder.




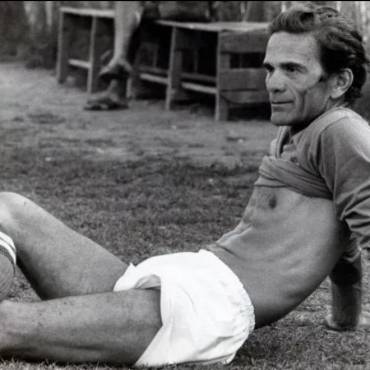
1 Commento
Una prosa che cattura e un finale che convince. Definitivo.
Aggiungi Commento