Nel capitolo sesto dei Promessi Sposi, Renzo va in cerca di Tonio per celebrare un matrimonio che doveva restare segreto, ma nello stesso tempo risultare «sacrosanto come l’avesse fatto il papa». Vedendo entrare l’ospite, la famiglia del testimone ha il terrore che Renzo si fermi per il pranzo, sottraendo anche un solo boccone a quel poco che passava il convento: ovvero «una piccola polenta bigia, di grano saraceno» che certamente mai avrebbe placato il robusto appetito di quella brigata. Polenta che, come scrive il Manzoni, viene scodellata «sulla tafferia di faggio, che stava apparecchiata a riceverla: e parve una piccola luna, in un gran cerchio di vapori». In effetti, il faggio era ed è ottimo per realizzare oggetti solidi e resistenti, creati lavorando una pianta che fin dal nome (fagus) ha a che fare con il cibo, come testimonia la voce greca da cui deriva.
L’abbiamo presa larga, ma ci sta: un faggio come quello del Piancone è a dir poco straordinario, un retaggio di altre ere. Basta riferire le sue misure per rendersene conto: nove metri e trenta la circonferenza del tronco, ventotto metri l’altezza, trenta la circonferenza della chioma, trecento anni l’età, secondo alcuni molti di più: qualcuno ne azzarda addirittura il doppio. È probabilmente il più imponente faggio d’Italia, non a caso eletto luogo del cuore dal Fai. Si trova sul territorio del comune di Casargo, in Alta Valsassina, poco sopra i 1500 metri, su un’erta piuttosto ripida: ci si arriva con qualche disagio. Da lontano, quando lo vedi spuntare, non ti pare così fuori taglia; semmai colpisce quel suo starsene sulle sue, nobilmente appartato. Soltanto quando ci sei accanto ne comprendi il motivo: il faggio del Piancone presenta un radicamento che è uno spettacolo nello spettacolo. È come se un altro faggio, nascosto e segreto, vivesse al buio lì sotto, altrettanto unico e immenso. Estese quanto la chioma, le radici di questo albero paiono contrappeso necessario a quello slancio vitale di foglie e di rami che sfida le nuvole e il cielo. Me ne sto sdraiato all’ombra, e protetto, mentre qualche bambino strilla di gioia e sale per i tronchi, fin dove è possibile osare; mi salta in mente il romanzo di Piero Chiara, Il balordo, storia dell’Anselmo Bordigoni, detto il Bordiga, uomo di due metri per 140 chili di stazza, smisurato proprio come la pianta sotto la quale soleva riposare, taciturno e apatico come sempre, lui pur valente musicista. L’albero preferito dal Bordiga pare fosse un ailanto, ma la sostanza non cambia: un tronco di questa natura accoglie, protegge, rassicura magari. Per un attimo mi scopro a pensare che i cieli andrebbero a zonzo se non ci fossero i boschi ad avvincerli e tenerli nei pressi.
Più prosaicamente, grazie alle sontuose radici i faggi sono particolarmente indicati per trattenere l’acqua che altrimenti rovinerebbe giù a valle. Mi piace pensarli come delle sentinelle del paesaggio: dove ci sono dei faggi, sai che sei in buone mani, e tante volte questo basta e conviene. Forse non a caso Leopardi in una sua lirica (Imitazione, canto XXXV) si è in qualche modo paragonato a una foglia di faggio:
Lungi dal proprio ramo,
povera foglia frale,
dove vai tu? – dal faggio
là dov’io nacqui, mi divise il vento.
Mi viene in mente quella volta – avrò avuto quindici anni a dir tanto – in gita con mio zio Carlo su per un monte. Lui macinava la salita con passo minimo e svelto, troppo svelto per un ragazzo di città, tanto più giovane quanto meno allenato. E mentre camminava, il Carlo se la cantava che era uno spettacolo, mentre io rantolavo a qualche metro di distanza. Magari senza saperlo, o per magica sintonia, viveva la salita come quei contadini celebrati da Tolstoj, secondo i quali se canti il lavoro viene meglio e la fatica non l’accusi nemmeno. Ma torniamo alla gita: a un certo punto ci perdiamo, ovvero non è chiaro da dove parta il sentiero giusto. Incrociamo un ragazzotto che porta a spasso qualche vacca in alpeggio, mio zio gli si rivolge in dialetto per avere la necessaria spiega. Il giovane gli consiglia di arrivare al “fó” e poi svoltare. Io il dialetto bergamasco lo capisco, ma quella parola lì mi mancava proprio. “Il fó è il faggio”, mi chiarisce lo zio. Allora è così che funziona: protetto dalle sue ampie radici, anche il faggio della gita con lo zio non tollerava estranei nei paraggi, e proprio per questo svolgeva al meglio il compito di indicare la via. Sta’ a vedere che questo ricordo l’ho capito solo adesso, dalle parti del faggio del Piancone.
——————————————
Per restare quasi in tema: una libreria a forma di albero.




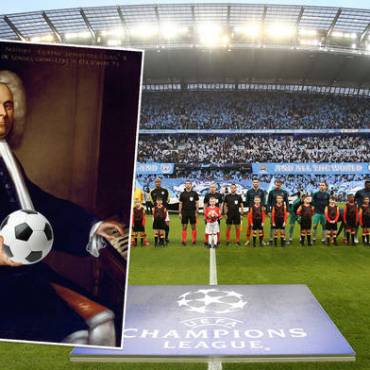

1 Commento
Confermo, visto da vicino fa impressione!
Aggiungi Commento