
Correva il 1977, altro secolo, altra era. A diciannove anni, per uno di quei casi della vita per cui se ti deve capitare ti capita, sono stato chiamato a far supplenza alle medie di un paesello della val Seriana in provincia di Bergamo. In quanto iscritto a Filosofia, ovviamente mi hanno assegnato la cattedra di Applicazioni tecniche. Arrivato sul posto, subito scopro che la mia classe è presso la sede staccata, ovvero l’oratorio. Vado in cerca della chiesa: finalmente entro in classe – una terza media perlopiù popolata da maschi – con un discreto ritardo sulla tabella di marcia. Parecchi ragazzi stipati in uno stanzone lungo e stretto. Mi accoglie un vociare in dialetto, non li guardo neanche in faccia e mi tuffo sul registro. Quelli mica smettono, figurarsi. Alzo lo sguardo, niente. Provo con un «Alùra?» [Allora?]. Silenzio immediato nella classe. Mi monto la testa, duplico con un «E proà a mocàla?» [E provare a smetterla?]. Dalla classe un grido terrorizzato: «Chèsto ‘l capèz , l’è mia ü terù» [Questo insegnante comprende il nostro dialetto, non è un figlio del nostro splendido Sud].
Rimediata un po’ di attenzione, mi avventuro sul programma: i ragazzi mi snocciolano tre o quattro argomenti di cui non so assolutamente niente. Traccheggio: «Il libro di testo?». Dal fondo si alza un ragazzino, si fa tutta l’aula con il libro in mano e me lo lascia sulla cattedra. Lo sfoglio, perlopiù non ci capisco una fava. Mi scappa l’occhio, il ragazzo è ancora lì in banda. Gli chiedo: «Devi dirmi qualcosa?». “Sì”, fa lui. «Dimmi», faccio io sul comprensivo. «Ma al la za lü che ‘l me pare al mà regalàt la baionèta del militare?» [Ma lo sa lei che mio padre mi ha regalato la baionetta di quando era militare?]. Non ho il tempo di approfondire, che il ragazzino estrae l’arma, se la gingilla per un secondo tra i risolini degli altri e poi la conficca in mezzo alla cattedra nel trionfo generale. Giuro, è tutto vero. Ora, mettetevi nei miei panni: potevo spedire il ragazzo dal preside, convocare i genitori, scrivere una nota sul registro, potevo anche chiamare i carabinieri. Ma era pur sempre il mio primo giorno di scuola. Ho dato un occhio fuori dalla finestra, in cerca di ispirazione. Si intravedeva il campetto dell’oratorio: «Facciamo due tiri?», ho buttato lì. Boato e fuga dei marrani, che recuperano un pallone e mi attendono belli schierati sul campo. Il mio primo giorno da insegnante l’ho passato così, un paio d’ore a rincorrere dei ragazzini felici.
Al tema scuola ho dedicato un’intera sezione del mio blog.




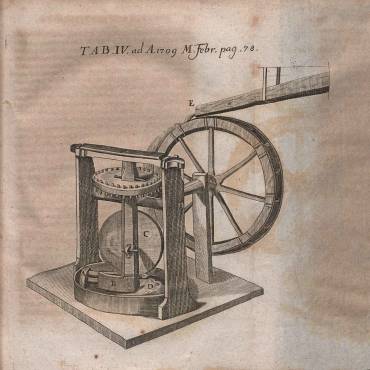
2 Commenti
Non è la prima volta che leggo questa pagina del Suo diario scolastico, e sempre annuso il profumo dell’autentica vocazione. È la stessa sensazione gratificante che mi ha allietato quando ho riletto “La conquista della Quinta C”. In tutti e due i casi è stato veramente un colpo di genio riuscire a mettere subito in campo la reazione meno scontata e più intelligente. Cosa in verità non facile e contro ogni istinto immediato, un capovolgimento delle sorti privo di ogni violenza, ma capace di tenere la situazione sotto controllo. Ragazzini in gruppo, poi…! No, non è affatto da tutti, e io L’ammiro per questa capacità di essere sfuggito alla trappola della sfida dei fanciulli e vincere alla grande. E, me lo conceda, mi piace molto immaginare la loro sorpresa ammirata. L’educatore più degno di questo appellativo: non li ha umiliati, ma semplicemente amati.
Il ritorno alla semplicità premia dempre
Aggiungi Commento