di Stefano Serpellini

C’è una maledizione che si proietta come un’ombra sui 106 anni dell’Atalanta e non sai mai se è frutto dei capricci del Fato o il riverbero dell’inconscio di noi bergamaschi, che viviamo ogni letizia con un senso di colpa, come se fosse peccato godere appieno delle gioie effimere. Questo è il dilemma che fa da sfondo al mio libro, L’anno della Coppa, recentemente pubblicato da Bolis Edizioni.
Il 2 giugno 1963 a San Siro la squadra nerazzurra vince la Coppa Italia, l’unico trofeo della sua storia, ma il successo è oscurato dall’agonia di Papa Giovanni, il pontefice bergamasco che si spegnerà il giorno successivo. Niente festeggiamenti, perché nella Bergamo pia e non ancora disincantata di quegli anni prevalgono il dolore e la mestizia per il Santo Padre morente rispetto all’euforia calcistica, che puntualmente svanisce non appena i tifosi lasciano la bolla felice degli spalti milanesi per rituffarsi nella quotidianità.
Cinquantasette anni dopo, il 10 marzo 2020, l’Atalanta raggiunge il suo picco storico accedendo ai quarti di finale di Champions League con il Paris Saint Germain dopo aver sconfitto a domicilio il Valencia. Ma, ancora una volta, è una festa breve come la traiettoria di un fuoco d’artificio, corredata da sorrisi tristi che sono il prodotto di un’angoscia collettiva: il Covid sta infatti mettendo in ginocchio una Bergamasca diventata spettrale, dove si sta rintanati in casa prede della paura e, se ci si affaccia al balcone, non è per vincere la noia del lockdown cantando, come si fa in altre parti d’Italia, bensì per scrutare le cupe processioni dei camion militari che portano via le bare da una terra dove non c’è più posto per seppellire i morti.
Legge di Murphy? Implicazioni astrali connesse al carattere saturnino della gente orobica? Mah, sembra più il castigo riservato a chi ha osato trasformarsi in Prometeo del pallone, rubando il fuoco agli dei del football per metterlo a disposizione della pedovalanza di provincia.
Stefano Serpellini presenterà il suo libro a Sarnico il 24 giugno nell’ambito di Fahrenheit 442. E il 16 giugno sarà a Sotto il Monte. La mia prossima newsletter mensile sarà dedicata al calcio, se non siete iscritti e volete riceverla potete farlo qui.



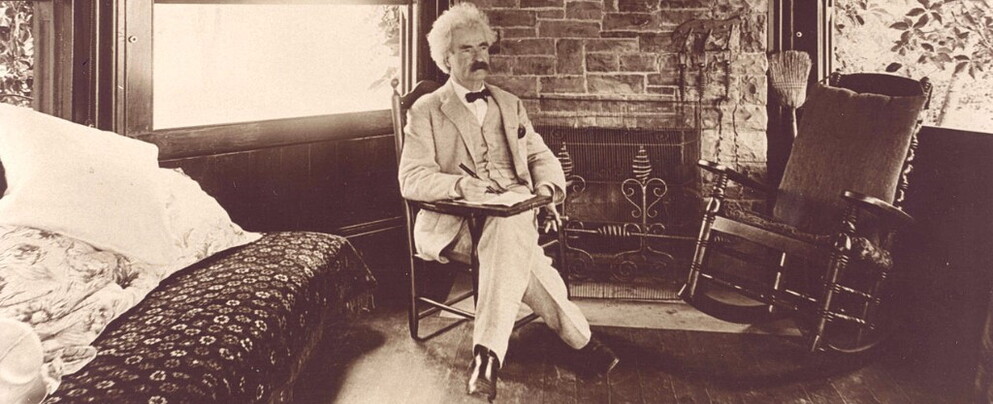

3 Commenti
Eh sì, anche alla Dea pensai… Non potetti non ricordare (pur non essendo all’epoca io ancora nato) quel 2 giugno (mio compleanno, toh…) 1963, quando l’Atalanta sconfisse il Torino per 3-1 e vinse la sua unica Coppa Italia. Nessuno fece in tempo a festeggiare, a Bergamo: l’unico Papa bergamasco della storia (Giovanni XXIII…anche lì, mica un Papa qualsiasi!), infatti, morì il giorno dopo. Come si poteva non pensare a un secolare disegno del demonio? Ma quando mai l’avevamo vista in Champions League l’Atalanta?
Non vi dico quanti si ricordarono nel 2019 di quella mia frase, nel lontano inverno del 2004, quando in “L’è sa Nedàl” (poi finita nell’album “Nömer dù – 2005) avevo cantato: “A mé i ma dàcc du portogài e trì fìch, ma mé öle l’Atalanta in Champions League!” (A me hanno dato due arance e tre fichi, ma io voglio l’Atalanta in Champions League!”). Ebbene, non solo l’Atalanta era arrivata in Champions, ma aveva pure superato la fase a gironi e gli ottavi di finale! Le due partite col Valencia, per quanto sportivamente eccelse, avrebbero portato per sempre con sé quel gusto terribilmente agrodolce che, cinquantasette anni prima, aveva avuto Atalanta-Torino, anzi forse di più, perché, con tutto il rispetto per l’impresa di Domenghini & soci, la Champions League non era la Coppa Italia! L’andata a Milano fu, forse, l’inconsapevole “sigla” del disastro umanitario e planetario che stava per compiersi, mentre il ritorno, a Valencia, due settimane dopo, a porte chiuse, regalò per sempre a tutti un’immagine angosciante, nonostante i quattro gol di Iličić.
Quando, la stagione successiva, la Dea si riconquistò l’incredibile diritto di giocare la Champions e, finalmente, pure quello di giocarla a Bergamo contro squadre del calibro di Liverpool, Ajax e Real Madrid… ecco che arrivò la seconda ondata del virus, quella che tenne a forza i bergamaschi lontano dal Gewiss Stadium. Bergamo, evidentemente, non aveva diritto a essere felice. Mai. La felicità era una colpa e io questa cosa l’avvertivo da sempre nel viso tirato di chi si sbronzava coi “soci” (gli amici), l’avvertivo in quel bisogno estremo che avevano i bergamaschi di dirsi l’un l’altro che erano i migliori, quasi sentissero sin dalla nascita una vocina che diceva loro che, invece, erano tutte stronzate.” (pagine 44 e 45 di “Terza appendice di Proud”, Silele Edizioni, 2021).
Avevo 12 anni, mi ricordo bene quel giorno, divisi tra la salute del papa e i gol di Domenghini. La nostra è un’epica in tono minore, per via del carattere orobico, si vede.
In effetti potrebbe avere a che fare con il nostro carattere: stiamo sempre molto attenti a esternare la gioia, quasi avessimo paura che il bello si possa sciogliere subito, come neve al primo sole.
Aggiungi Commento