Io dico e affermo che v’è rapporto stretto e consanguineo tra l’espressioni di una certa lingua e il carattere di quel popolo, per tacer della realtà che desso popolo tocca con mano e per ciò stesso riesce a concepire. Incipit da illuminista italico, ma il concetto ha ancora corso legale, eccome. Vi siete mai chiesti, ad esempio, perché in terra orobica “felicità” non ha corrispondente voce? Certo che per noi autoctoni la felicità esiste, ma non abbiamo la parola esatta per dirla. Forse i bergamaschi, gente concreta e spiccia, ma certamente vera, temono che una felicità di qualsivoglia dimensione si tiri sempre dietro un prezzo da pagare; per cui meglio stare un passo indietro, cauti e schisci, onde evitare eccessi. Come a dire: il deluso è per forza figlio dell’illuso. Faccenda questa, o sentimento, che porta a viver non sempre appieno le cose belle, a battezzarle già per transitorie prima ancora che si rivelino per tali. Da qui le emozioni dispensate con il contagocce, i sentimenti trattenuti, lacrime e soprattutto smancerie debitamente tenute in saccoccia, con la mano a rinnovata protezione. Il bergamasco le lacrime le sconta vivendo, parafrasando il poeta. Mi viene in mente un passo del mio ultimo romanzo, La cantante, dove il tema viene fuori bello netto. Come mai, mi chiedevo per l’appunto, il dialetto bergamasco bisticcia con la felicità al punto di non attribuirle un nome, mentre coi soldi è tutto un florilegio di espressioni?
«Forse non tutti sanno che in bergamasco felicità non ha voce: puoi spulciare fior di dizionari e ci trovi giusto la replica dell’italica versione. A domanda specifica, «Cóme àla?», il bergamasco si contenta di un semplice «Stó bé» o di un ecclesiastico «de papa»; salvo svariare, ma di rado, nel vivace contentèssa. Ben altro discorso per i soldi: qui la cornucopia ostenta l’ovvio sólcc, la semplice monéda, l’immaginifico cöcagna, l’orecchiabile danér, il tangibile arzàm, il popolare conquìbus, con manovra spiccia delle prime dita a chiarire il latinorum; la ruvida palanca, il minimo béssì, il lauto stipèndio, vestito all’italiana perché non ti viene quasi mai elargito in dialetto; e ancora gli schèi di veneta fattura, contrabbandati in zona come ghèi, il voluminoso cassa, l’orgoglioso guadàgn, il bancario valüda, il paradisiaco richèssa, con tanto d’occhi a sbalordire».
I soldi non fanno la felicità, d’accordo, ma son lì belli concreti, li puoi sfogliare per le dita o tintinnare per le tasche. Ed è più facile, mi sa, trovar parole per le cose che passan per le mani che per stati d’animo o emozioni che si teme possano durare al pari di certe farfalle, che hanno in sorte un giorno solo per volare. Dedico questa mia digressione antropologico-linguistico-monetaria a zio Paperone, in particolare al di lui deposito, che proprio in questi giorni compie la bellezza di 70 anni. Il forziere compare per la prima volta in una puntata del 1941, lo sapevate? Chissà che ne avrebbe scritto Giulio Giorello, che persino a fumetti era un portento di memoria e riflessioni.





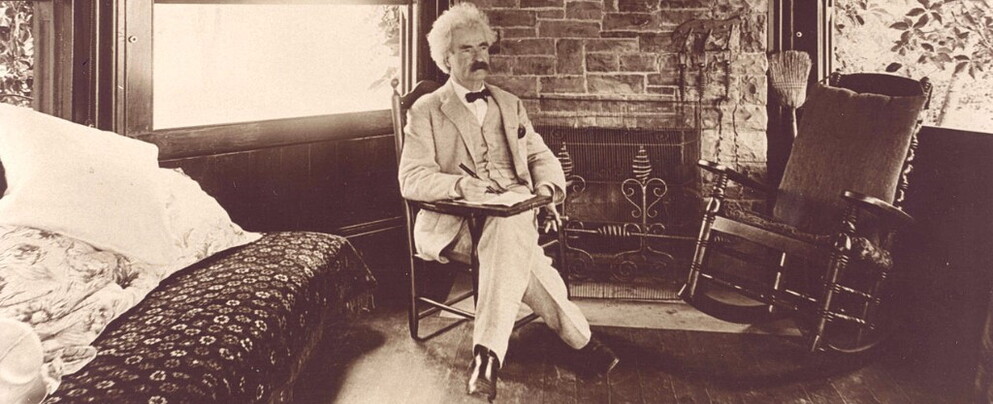
Aggiungi Commento